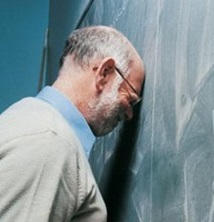Proprio mentre il sindaco di Bergamo Giorgio Gori era in tour per la Lombardia a presentare il suo pacchetto di offerte “ruba imprese”, un articolo
Categoria: Commenti
Siamo al ridicolo! Ora si encomia anche la normalità
La notizia dovrebbe essere quella che Beppe Parazzini ha ricevuto dalle Forze Armate un encomio, per il suo valoroso comportamento, in occasione della manifestazione in
Battuta d’arresto per il Pd. E l’altro Matteo esulta
Diceva Enrico Cuccia che le azioni non si contano, si “pesano”. Converrà seguire le orme del padre nobile di Mediobanca se si vuole analizzare il
“Buonascuola”? No, grazie. Non mi fido più di nessuno
Io non sono un grosso esperto di politica: ogni volta che ho dato retta ad un politico, anche se era un amico di vecchia data,
Expo a rischio sagra, ma farà comunque bene al Pil
Forse neanche il primo novembre, quando l’Expo sarà definitivamente chiusa, ci sarà un giudizio univoco se sia stato un successo o meno. Del resto, a
Il trionfo del “Tengo famiglia” in un Paese senza etica
“La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta: Tengo famiglia”. La celebre battuta di Leo Longanesi ha più di 60 anni ma non perde mai
Centenario della prima guerra, che amarezza i silenzi di PalaFrizzoni
Ci ritorno, ossessivamente, ripetitivamente: è la cimminite, da cui non mi riesce di liberarmi. E’ una fissa che vi infliggo: gira che ti rigira, a
L’analisi / Le relazioni industriali alla prova degli scioperi
di Davide Mosca* La Germania sta conoscendo in questi giorni lo sciopero più lungo della sua storia. Il braccio di ferro, questa volta, non interessa
Albinoleffe, il grande sogno spezzato dal dna bergamasco
E’ una storia molto bergamasca, quella dell’Albinoleffe, precipitato nei Dilettanti dopo un decennio nel calcio d’élite (con tanto di serie A sfiorata), al termine di
Poveri italiani, ormai come rane a bagnomaria
Vi invito a leggere la splendida poesia di Baudelaire “Remords posthume” e, subito dopo, quella, assai meno felice, del nostro Olindo Guerrini, che si intitola