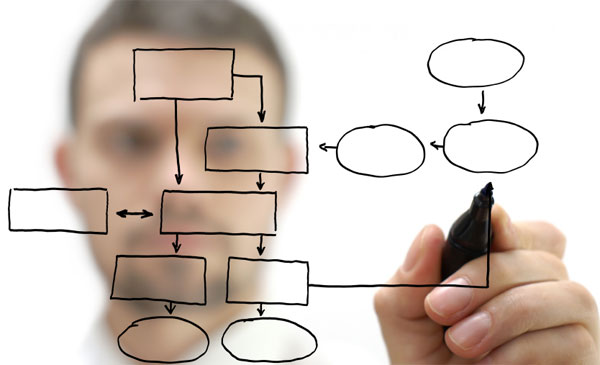Il black cab sta a Londra quanto la regina sta a Buckingham Palace. Non stupisce che al lancio di Uber i taxisti abbiano protestato ferocemente,
Categoria: Una bergamasca a Londra
Se i brand del lusso scoprono il “traino” del museo
Il pubblico fa le code per vedere borsette, cinture e foulard. Non per comprare in saldo, solo per guardare. Sembra un controsenso, vetrine e negozi
Che fortuna essere un italiano nella capitale inglese
Che a Londra ci siano molti italiani non è una novità. Che tutti questi italiani pensino di essere gli unici a parlare una lingua esotica
Il rito del tè inglese ora “seduce” anche i salutisti
Quello che tiene uniti gli inglesi non è la regina, ma il tè, seguito dal cricket. Nessuno li disprezza, molti li amano, la maggior parte
Se il dipendente si muove l’azienda risparmia
Viviamo in un mondo dove tutto e tutti sono sempre più connessi. Tutto questo ha delle implicazioni sempre più visibili nel lavoro e nella società.
Perché qui la febbre dell’Expo non è salita
Ci sarà cibo, design e cultura. La stampa inglese non ha dato spazio all’apertura dell’Expo 2015, forse troppo preoccupata dell’arrivo della principessa Charlotte e a
La coperta troppo corta della “Generation rent”
Essere proprietari della casa in cui si vive non è più la norma per la mia generazione. Tra i pochi che scelgono l’affitto come stile
Stagisti: raccomandare va bene, a patto che…
Dopo le vacanze di Pasqua entreremo improvvisamente nell’ultimo trimestre scolastico. Per gli studenti universitari significa soprattutto trovare uno stage estivo nel settore di interesse o
Il coraggio dei manager che scelgono la “libertà”
Scoprire che il tuo capo guadagna il doppio o anche il quadruplo di te è un’esperienza demoralizzante. Ma quando il divario tra te e l’amministratore
Disoccupato e sessantenne? C’è una banca che ti cerca
Perdere il lavoro a dieci anni dalla pensione ha il sapore di una sentenza definitiva. E’ una storia dura, triste, che abbiamo sentito ormai troppe